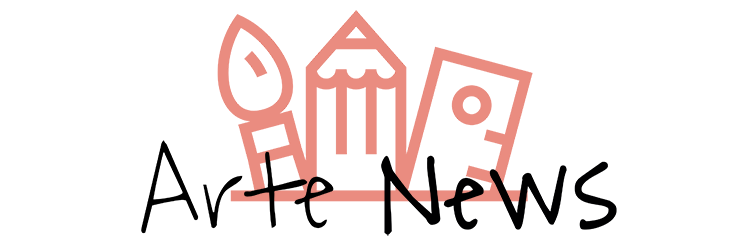Life of a Repentant è un reportage fotografico che racconta la storia di Michele, la storia di un pentito di Camorra e del suo reingresso nella società
Life of a Repentant è un reportage fotografico che racconta la storia di Michele, la storia di un pentito di Camorra e del suo reingresso nella società dopo la fine del programma di protezione per i collaboratori di giustizia. La fotografa Giulia Mozzini ha incontrato Michele alla fine del 2018, un anno prima che il programma governativo si concludesse. “Si fidava di me”, spiega Mozzini, “e ho potuto documentare la sua vita per un anno intero. Insieme abbiamo trascritto i diari che aveva scritto in carcere su bloc-notes a quadretti, le cui copertine erano da tempo scomparse. Diari che descrivono il suo lento risveglio di coscienza e il suo riscatto”. Le immagini che compongono il reportage sono il frutto di questo incontro e di quella collaborazione. L’opera è stata esposta nelle gallerie del Passante Ferroviario di Porta Venezia grazie alla collaborazione con Artepassante.

Il progetto Life of a Repentant
Secondo un rapporto prodotto dalla polizia di Stato nel 2016, si legge nella presentazione dell’opera, il totale della “popolazione protetta” in Italia è di 6.192 persone, di cui 1277 sono collaboratori e testimoni della giustizia e quasi 5000 i loro familiari: mogli, figli, fratelli, cognati, nipoti, conviventi. L’organizzazione criminale con il maggior numero di collaboratori di giustizia è la Camorra, con oltre 600 pentiti. Nonostante le agevolazioni materiali offerte dalla collaborazione, non esiste un vero programma di reintegrazione e molti di loro, affrontando le difficoltà che il nuovo ingresso nella società civile comporta, fanno un passo indietro e riprendono le vecchie abitudini, tornando presto in prigione. Tra coloro che resistono e cercano di adattarsi alle nuove regole, molti non riescono a raggiungere la stabilità economica perché hanno posizioni lavorative che spesso non consentono la crescita professionale e bruciano i loro guadagni per mantenere uno stile di vita ancora troppo elevato rispetto alle loro nuove condizioni . Ci sono pochissimi che fanno carriera e riescono a stabilizzarsi nella società. Michele è uno di questi.
La storia di Michele
“Sono uscito di galera con la consapevolezza di essere indietro anni luce rispetto agli altri”, racconta Michele nella presentazione del reportage. “Non conoscevo nemmeno Facebook, per dare un metro di misura di quanto fossi indietro. I primi mesi ero in detenzione domiciliare , potevo uscire solo dalle 10 alle 12. Scrissi al magistrato di sorveglianza chiedendogli un’autorizzazione molto dettagliata per poter trovare un lavoro ed effettuare eventuali prove prima di presentargli il contratto. Così mi rimboccai le maniche e la mattina iniziai a presentare cv a raffica ( ovviamente con referenze false) a qualunque posto facesse da mangiare. Non mi interessavano gli orari, le mansioni e la paga, volevo solo lavorare. Dopo mille “le faremo sapere”, iniziai la prima prova, il posto era carino e in pieno centro. Il titolare mi mise in uno scantinato insieme a tre ragazzi del Bangladesh a lavare piatti, stoviglie, tritare cipolle e pulire patate”.
“Lavoravo sodo – racconta ancora Michele -: facevo 13 ore al giorno per 6 giorni la settimana per 800 euro al mese. Praticamente i soldi che facevo con 2 scooter rubati a 15 anni”. “Lo chef iniziò a infastidirmi così tanto che iniziai a fomentarlo: strategia tipica dei clan dei Casalesi”, ripercorre il pentito. “Io sentivo di meritare il suo posto e lo volevo, per me rappresentava un modo per saziare sia il mio egocentrismo e soprattutto per dimostrare che gli anni che ero stato in galera non erano stati perduti. Iniziai a metterlo contro la direzione finché lui non si sentì così preso da lasciare il proprio posto di lavoro: nel momento in cui lui diede le sue dimissioni si aspettava che io facessi lo stesso, cosa che io non feci perché io volevo il suo posto e non avevo fatto tutto questo per essere il secondo. Diceva sempre Luigi Diana, un killer, che il secondo non è altro che il migliore dei perdenti e io avevo perso troppo per vivere ancora da perdente. Diventai chef, ci misi corpo, cuore, anima, mi sacrificai tanto e tutt’ora oggi lo faccio. Mi accollai responsabilità di cui l’altro chef non si era mai preso carico, impostai una linea diversa dalla sua: non ero il capo della cucina ma il leader, ero quello che quando c’era da fare un lavoro di m… era il primo, che quando c’era da stare in cella a meno 20 gradi era sempre presente, quello che si guadagnava il rispetto dei musulmani in cucina”.

Chi è Giulia Mozzini
Giulia Mozzini è una fotografa specializzata in storytelling. Nata a Verona nel 1995, dopo il diploma al liceo classico si trasferisce a Milano nel 2014 per studiare fotografia all’Istituto Italiano di Fotografia. Si specializza in fotogiornalismo alla John Kaverdash Academy, dove tra il 2016 e il 2017 ha conseguito il master in fotografia di reportage, con il docente e reporter Alessandro Grassani. Nel 2016 espone alla Galleria Meravigli di Milano collaborando con Eyesopen!Magazine, nel 2018 partecipa al Milano Photofestival con l’opera “Morocco”, esposto poi anche durante la mostra collettiva “Contemporaneamenti 2018” , indetta dalla galleria l’Arsenale di Iseo. Collabora come giornalista con l’associazione di fotogiornalismo “Nessunopress” e si occupa di reportage incentrati sul sociale, indagando l’individuo attraverso il racconto della sua storia personale per portare alla luce realtà ancora non conosciute.